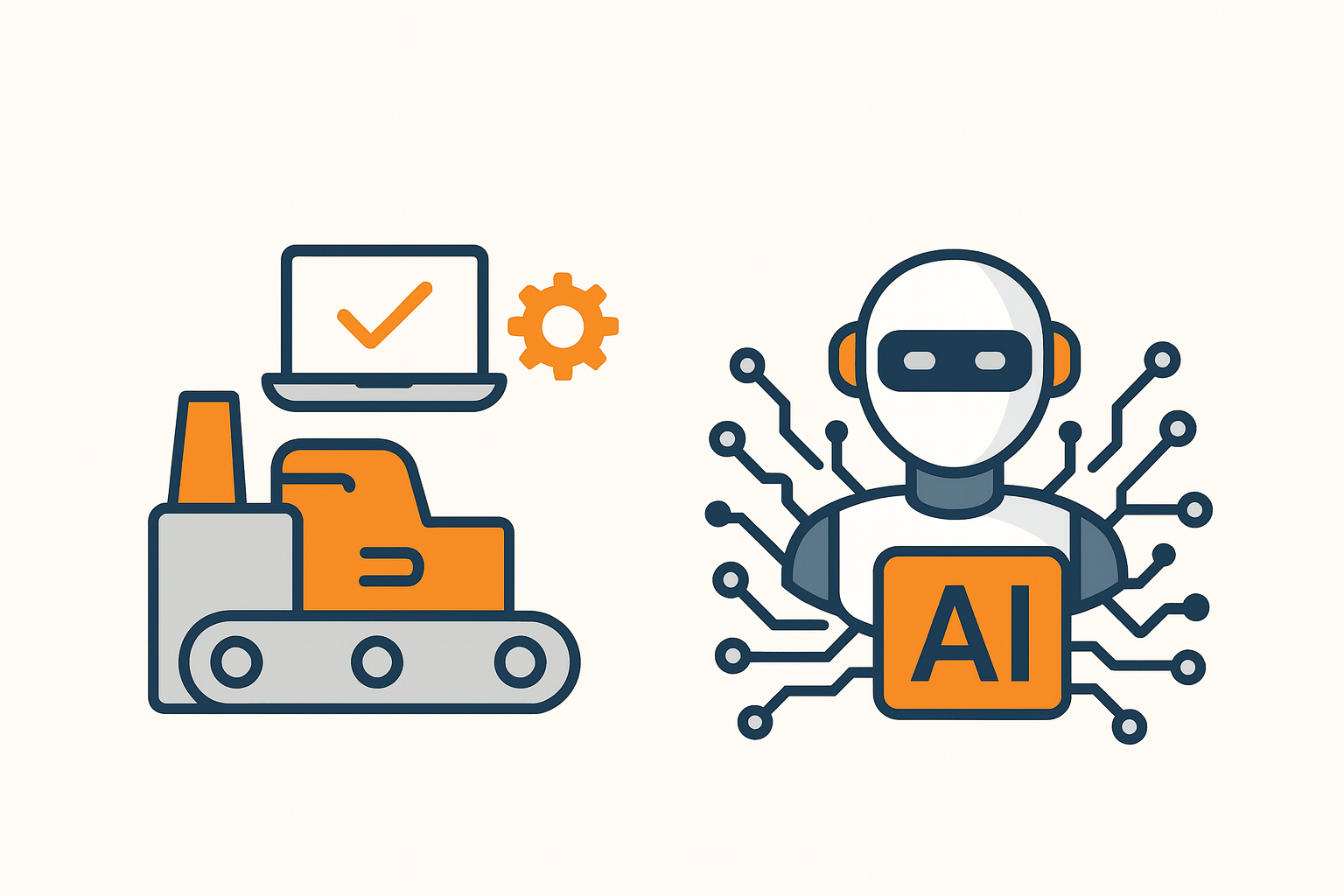Expert talk con Davide Benassi: Cambiare mentalità, non solo tecnologia

La vera innovazione è: cultura, strategia e persone

Sara Strizzolo
22 Maggio 2025
Software driven-innovation non significa sviluppare il lato software in prodotti già esistenti, significa cambiare il modo in cui quei prodotti nascono, funzionano e crescono nel tempo. È il passaggio da oggetti statici a sistemi intelligenti, capaci di evolversi nel tempo, generare nuovi ricavi e migliorare l’esperienza d’uso in modi inaspettati.
In questa intervista, Davide Benassi, IoT & UX Manager con esperienza in realtà come Vimec, LiftingItaly e Immergas (attive nei settori HVAC e mobilità personale), ci spiega le implicazioni di questo trend nel mondo manifatturiero.
Con esempi concreti, Davide approfondisce perché il vero valore di questa transizione non è solo tecnologico, ma strategico: dai nuovi modelli di business, alla trasformazione delle competenze, fino al cambio radicale di mentalità verso il fallimento e il miglioramento continuo.
Ciao Davide, benvenuto e grazie per essere qui con noi oggi! Partirei subito con un paio di domande. Di che cosa ti occupi attualmente e qual è il tuo background?
Mi occupo di IoT applicato ai prodotti e di user experience. Sono laureato in ingegneria elettronica e fin dal primo progetto ho sempre lavorato sulle specifiche hardware e software dei prodotti inserendo, come fondamentale, nelle specifiche dei prodotti il requisito della connettività.
Nella mia carriera ho avuto sia la possibilità di seguire lo sviluppo dei prodotti che di osservare come le persone li utilizzano effettivamente sul campo. Questo mi ha fatto comprendere quanto una diversa esperienza d’uso possa influenzare in modo significativo la percezione del prodotto.
Entrando nel cuore della software-driven innovation, che cosa ne pensi di questo trend e come lo vedi effettivamente cambiato dall'inizio della tua carriera ad oggi?
Penso che questo sia un trend che rivoluzionerà il modo di progettare, di costruire e utilizzare i prodotti nonostante sia un mondo ancora in fase di sviluppo.
Ti faccio un esempio molto semplice: la cappa della cucina. Fino a qualche anno fa era un oggetto “brutto”, spesso nascosto all’interno di un mobile, con un semplice interruttore per accendere e spegnere le luci integrate, che tra l’altro non illuminavano nemmeno adeguatamente il piano di lavoro. Grazie invece alle tecnologie IoT la cappa della cucina è diventata un elemento di design essenziale. Oggi fornisce illuminazione, adattabile in funzione della presenza delle persone o meno, ed è in grado di collegarsi ad altri elettrodomestici, come il piano cottura, per sapere quando attivarsi, come farlo, e con quale intensità. Regola quindi velocità e funzionamento in base a ciò che si sta cucinando.
Inoltre, può essere integrata con sistemi di gestione del building più avanzati, come quelli domotici, sia in contesti domestici che in edifici più complessi.
Ecco quindi come, da una semplice cappa priva di qualsiasi componente software, siamo arrivati a un prodotto in cui
il software è diventato un elemento centrale nello sviluppo e nella progettazione.
Secondo te, seppure ancora prematuro, qual è l'impatto che vedi concretamente?
Dal mio punto di vista la software-driven innovation avrà un forte impatto sul mondo manifatturiero, sia dal punto di vista della progettazione che dello sviluppo e della produzione dei prodotti stessi.
I prodotti si potranno evolvere dal punto di vista funzionale nel tempo, grazie all'innovazione del software, e potranno essere progettati con un ciclo di vita molto più lungo, che dal punto di vista della sostenibilità è sicuramente un aspetto positivo.
Se ragioniamo invece sui ricavi, si sposteranno sempre più dalla semplice vendita del solo prodotto ai servizi. Il servizio garantisce un ricavo nel tempo più costante e continuativo. Di conseguenza, le aziende potrebbero spostare parte delle risorse dalla progettazione di hardware alla progettazione del software.
Se il vero valore passa dal prodotto al servizio, l’azienda può permettersi di utilizzare hardware più generico e meno customizzato, riducendo così i costi di progettazione di componenti esclusivi e sfruttando soluzioni general purpose prodotte su larga scala.
Facendo riferimento alle diverse realtà in cui hai lavorato, quali sono i primi segnali che spingono davvero un’azienda manifatturiera ad investire nel software come valore aggiunto?
I primi segnali arrivano sempre dal mercato. Quando il cliente stesso comincia ad essere più interessato alle funzionalità, all'esperienza d'uso e a come il prodotto stesso può soddisfare le proprie esigenze, allora è necessario cominciare a fare dei cambiamenti.
Prendiamo come esempio una caldaia, o più in generale un sistema per la generazione di acqua calda. Una cosa è acquistare un dispositivo che semplicemente si accende e si spegne quando l’utente decide di attivarlo perché ha freddo o caldo; ben altra cosa è offrire un sistema intelligente, capace di rilevare la presenza di persone all’interno dell’edificio, monitorare la temperatura interna ed esterna, valutare il costo dell’energia, e quindi regolare autonomamente i parametri di funzionamento in base a queste variabili. Il risultato è un consumo energetico ottimizzato e, allo stesso tempo, un maggiore livello di comfort per l’utente.
Questa è la vera differenza tra un sistema tradizionale e un sistema smart e connesso, governato dal software.
Ecco, una volta che effettivamente l'azienda decide di adottare questo approccio, come si concretizza lo sviluppo del prodotto?
La
progettazione cambia radicalmente, così come l’approccio alla fase di definizione e specifica del prodotto. Non esiste più il modello tradizionale in cui l’ufficio tecnico o R&D riceve delle specifiche dalla rete vendita e si limita a realizzare un prodotto entro un certo costo. Oggi l’obiettivo è
sviluppare prodotti che abilitino servizi, i quali a loro volta possano
generare nuove fonti di ricavo. Per farlo, è fondamentale introdurre nuove
figure professionali in grado di raccogliere esigenze e input provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’azienda, e di sintetizzarli in una visione progettuale condivisa. Non si tratta solo di mediare, ma di svolgere un ruolo
di collegamento strategico tra l’area business, quella tecnica, la produzione e il cliente finale. Perché comunque i prodotti oggi sono pensati per generare
servizi, interni o esterni, e quindi diventa essenziale mettere insieme tutte queste componenti fin dalle fasi iniziali, progettando il prodotto in modo che tutti all'interno dell'azienda stessa lo sentano proprio e lo migliorino.
Con il
rilascio graduale delle funzionalità, immagino che vengano avviati fin da subito dei
test di validazione per verificarne l'efficacia. Come funziona esattamente questo processo?
Sì, assolutamente. Una volta rilasciato il
primo step di sviluppo, vengono già pianificati i successivi. L’aspetto più importante però è che questi step
possono essere modificati in corso d’opera. Dopo il rilascio iniziale, si raccolgono feedback dal mercato e dall’utilizzo sul campo. Se tutto funziona come previsto, si prosegue con le fasi successive: realizzazione, test sul campo, validazione finale. In caso contrario, è possibile apportare delle revisioni. Questo approccio consente di
correggere la rotta lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.
Questo nuovo approccio, definito agile, mette molto in discussione l'idea negativa che abbiamo del fallimento. In questo caso “fallire” e capire subito che qualcosa non sta funzionando è positivo. Ma come cambia questa percezione in un’azienda manifatturiera?
Cambia radicalmente. Seguendo un approccio
waterfall, si sviluppa un prodotto seguendo fasi sequenziali. In quel caso, o hai successo oppure hai fallito. Con un approccio iterativo, invece, si entra in una logica di
miglioramento continuo. Il concetto stesso di “fallimento” cambia: non scompare completamente, ma viene rielaborato perché
non si crea un prodotto che non può essere modificato, ma un sistema che può evolvere nel tempo.
Visto che abbiamo parlato più in generale del ciclo di progettazione, ci puoi fare ora un esempio di qualche applicazione che è riuscita a cambiare un determinato processo o la fruibilità di un determinato prodotto?
Sì, un esempio concreto riguarda gli ultimi prodotti che abbiamo sviluppato, nei quali è stata integrata anche un’applicazione dedicata. Nei prodotti precedenti, durante le fasi di
produzione e collaudo, era necessario utilizzare
strumenti esterni, spesso costosi, per effettuare i controlli. Inoltre, in caso di problemi, era difficile ottenere informazioni dettagliate sul guasto o sull’effettivo utilizzo del prodotto. Oggi, grazie all’introduzione dell'applicazione collegata a un prodotto
gestito via software, connesso e ricco di dati, l’app stessa
guida il processo di collaudo,
assiste l’installazione e supporta sia l’utente nell’utilizzo del prodotto, sia il tecnico nella diagnosi e risoluzione dei problemi. Quindi è cambiato completamente il modo di interagire con il prodotto stesso.
Facendo riferimento alle varie
app
di cui ti sei occupato, che tipo di servizi si possono effettivamente offrire?
I servizi digitali sono strettamente legati all’esperienza d’uso del prodotto. Se pensiamo all’utente finale, l’obiettivo è aiutarlo a utilizzare il prodotto nel modo più semplice e autonomo possibile, guidandolo anche nei momenti di difficoltà, facendo in modo che il cliente non debba chiamare il servizio di assistenza tecnica. Questo significa ridurre i tempi di inattività del prodotto.
Per quanto riguarda il caso dell'assistenza tecnica, l’applicazione è in grado di collegarsi ai servizi cloud, offrendo funzionalità come il troubleshooting, il controllo remoto, il monitoraggio e la configurazione del dispositivo. Si tratta di un vantaggio concreto rispetto ai prodotti tradizionali, dove la configurazione può essere complessa e le procedure di assistenza sono spesso affidate a manuali cartacei, talvolta incompleti o non aggiornati. In questo contesto, la velocità di ricerca e l’accesso alle informazioni giuste rappresentano i veri valori aggiunti di questi servizi.
Il cliente percepisce il prodotto di un livello di fascia superiore
aumentando il valore percepito del prodotto in modo significativo.
Il vero valore della connettività sta anche in questo: una percezione più alta del prodotto, processi più efficienti e un miglioramento concreto dell’esperienza utente. Secondo te, quanto questi aspetti vengono realmente compresi e valorizzati dal business?
Inizialmente è sicuramente difficile dare un valore concreto ai dati e alla connettività, ma se andiamo a analizzare qualche caso d'uso è abbastanza semplice capire qual è il valore di questi servizi.
Facciamo un esempio: viviamo in un mondo frenetico, pieno di informazioni, che viaggia a velocità assurde. Pensiamo ad una persona che per lavoro deve viaggiare, quindi ha necessità di prendere i biglietti del treno, dell'aereo, prenotare hotel, taxi. Dovrà spendere tanto tempo per acquistare singolarmente tutti i biglietti. Se invece utilizza un servizio integrato, capace di organizzare tutto automaticamente in base alle sue necessità, il risparmio di tempo diventa un valore reale perché la persona sarà disposta a pagare per usufruire di questo servizio.
Un altro esempio: oggi si tendono a
noleggiare dei prodotti
piuttosto che venderli. Noleggio un prodotto perché non mi voglio preoccupare del guasto, non mi voglio interessare di nient'altro se non che il prodotto funzioni sempre al 100%. Per offrire un servizio di questo tipo, il prodotto deve essere connesso perché l’azienda deve intervenire prima che il prodotto si guasti conoscendo conoscendo in tempo reale lo stato e l’intero ciclo di vita del prodotto. Senza connettività, tutto questo
non sarebbe possibile. Quindi il vero valore della connettività sta proprio nella
possibilità di abilitare servizi che prima non c’erano.
Hai fatto esempi molto concreti che mostrano il valore reale della connettività. Tuttavia, per giustificare questi investimenti, è inevitabile che il business voglia misurare l’efficacia dell’iniziativa anche da un punto di vista economico. Quali KPI e orizzonti temporali vengono solitamente considerati per valutare concretamente il ritorno di questo approccio?
I KPI più comunemente utilizzati sono: il risparmio di tempo nei servizi di assistenza tecnica, sia per l’assistenza interna che per quella esterna.
Un altro indicatore fondamentale è l’NPS (Net Promoter Score), perché l’introduzione della connettività cambia radicalmente la percezione del prodotto da parte dei clienti. Un prodotto connesso, infatti, può adattare le proprie funzionalità alle esigenze dell’utente, offrendo un’esperienza più personalizzata e flessibile. C’è un risparmio di tempo anche per le aree marketing e progettazione: conoscere nel dettaglio come i prodotti vengono realmente utilizzati, i pattern di utilizzo consente di raccogliere dati preziosi che possono abbreviare il percorso di apprendimento per la progettazione.
Quanto è complesso, per il business, definire dei range di riferimento per valutare i risultati ottenuti, e decidere se un’attività può considerarsi validata o meno?
È una valutazione piuttosto difficile, perché fino ad oggi non è mai stata affrontata in modo strutturato. Bisogna partire da un’ipotesi iniziale, che viene poi verificata e corretta nel tempo. Ovviamente vengono effettuati diversi test, sia interni che esterni, e delle valutazioni per individuare i cosiddetti “tempi morti” e capire come possano essere recuperati attraverso i nuovi servizi. In base a ciò che si riesce effettivamente a misurare, si procede a modificare e ottimizzare l’approccio. In linea generale, per rientrare dagli investimenti legati a questi servizi, sono necessari almeno due o tre anni.
Visto che siamo entrati in tema business, quali modelli secondo te possono valorizzare al meglio l’IoT e che vengono recepiti meglio dalla parte economica dell’azienda?
Sicuramente il modello freemium può essere una buona soluzione nelle fasi iniziali, perché devi far conoscere il prodotto e i servizi associati, soprattutto quando si tratta di novità per cui non esiste ancora uno storico in grado di definire con precisione qual è il vero valore che puoi dare ai tuoi servizi.
Poi si può passare sicuramente a un modello basato sulla soddisfazione del cliente (satisfaction-based), che risulta particolarmente efficace una volta che il servizio è stato effettivamente adottato. Questo è il modello ideale per la gestione di servizi che prevedono costi legati alla connettività e alla manutenzione, e che quindi hanno bisogno di entrate continuative.
In alcuni settori/casi specifici, può essere valido anche il
modello pay-per-use, soprattutto quando il prodotto non viene utilizzato in modo continuativo. In situazioni del genere, un abbonamento fisso potrebbe non essere percepito positivamente dal cliente, mentre un pagamento basato sull’effettivo utilizzo potrebbe rappresentare la soluzione più adatta.
Abbiamo parlato del contesto attuale, che negli ultimi due anni ha già vissuto un cambiamento significativo, soprattutto sul piano tecnologico, con il forte impatto dell’AI generativa. Secondo te, in che modo l’intelligenza artificiale influenzerà lo sviluppo dei prodotti e come pensi che si evolverà il concetto stesso di software-driven innovation?
Io penso che l'AI generativa sia una grande opportunità per lo sviluppo di una generazione di prodotti e servizi perché con l'AI è possibile trasformare completamente l'interazione, quindi l'esperienza d'uso, con i prodotti. L'AI sostanzialmente aggiunge una componente ”umana” che ti permette di dialogare con il dispositivo fisico in maniera molto simile a come si comunicherebbe con una persona. Prima il prodotto poteva essere visto come una “scatola nera” incomprensibile, adesso diventa un oggetto con il quale posso comunicare e quindi è molto più semplice per la persona o per il tecnico interagire con questo tipo di prodotti.
Ti faccio solo un'ultima domanda. Che consiglio daresti a un'azienda manifatturiera che vuole puntare sul software? Magari qualcosa che tu stesso volevi sapere all'inizio del tuo percorso.
Il consiglio che posso dare a un’azienda che vuole intraprendere questo
percorso di trasformazione è di valutare attentamente, fin dall’inizio, se le persone coinvolte sono davvero pronte a seguirlo. Non è un processo semplice. Per questo è fondamentale che l’azienda analizzi con attenzione l’impatto del cambiamento,
coinvolgendo le persone fin
dalle prime fasi e preparandole adeguatamente, anche attraverso la
formazione.
Questo è un punto davvero interessante. Hai messo l’accento su un elemento spesso sottovalutato: le persone. È fondamentale smettere di considerare l’approccio software-driven come un semplice costo tecnico e iniziare a vederlo come un investimento strategico, in cui il coinvolgimento e la preparazione delle persone rappresentano la vera leva per il successo.
Davide, grazie davvero per il tuo tempo. È stato un piacere ascoltarti, grazie per i preziosi spunti che sono sicura saranno di grande valore per tutte le aziende che stanno cercando o che vogliono approcciarsi al software.
👉 Vuoi scoprire quanto è pronta la tua azienda ad integrare l’AI nei prodotti?
Compila l’AI Readiness Assessment (ti basterà qualche minuto)